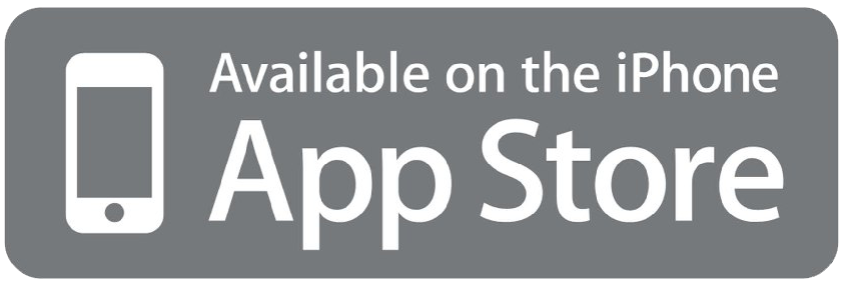(ilmanifesto.it)
Sly Stone, nato Sylvester Stewart, è ricordato per alcuni capolavori della black music, per avere ideato uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi. L’adolescenza è caratterizzata da uno stretto legame con la musica, la partecipazione al coro gospel della sua chiesa, a Vallejo (California) e la formazione di una prima band, gli Stewart Four. A undici anni suona tastiere, chitarra, basso, batteria, oltre a cantare. Tra le esperienze musicali la più significativa è quella dei Viscaynes, gruppo doo wop con cui suona nei primi anni Sessanta.
Sly si immerge nella carriera professionistica partendo dall’attività di dj in una radio dell’area di San Francisco, la KSOL. Entra nella Autumn Records di San Francisco e incomincia l’attività di produttore, lavorando per Beau Brummels e Mojo Men e con i Great Society. Suona come Marvin Gaye e Dionne Warwick. Ma incomincia a mettere le basi per il suo grande progetto: Sly and the Stoners. Il primo album, pubblicato nel 1967, si intitola A Whole New Thing. Nell’aprile 1968 esce Dance to the Music, un mix di soul, gospel, rock e psichedelia. Il terzo album Life è tra i più pulsanti della loro discografia. Stand esce poche settimane prima della trionfale apparizione al Festival di Woodstock e all’Harlem Cultural Festival di New York. La band vende un sacco di dischi, ma Sly sprofonda in un abisso di abusi, cocaina, alcol, eccessi di ogni tipo. Le sue finanze vengono erose oltre che per i soldi spesi in droghe e in lussi di vario tipo, anche dalle continue penali che deve pagare per concerti saltati e contratti non rispettati. Trascorre giorni e giorni in studio di registrazione senza mai dormire, sempre sotto effetto di sostanze, continuando a incidere musica, ad aggiungere strumenti e sovraincisioni ma non riuscendo mai a concludere nulla di concreto. Alla fine riesce a pubblicare quello che rimane un capolavoro assoluto della black music. There’s a Riot Goin’ on, accompagnato da un’iconica copertina con la bandiera americana con il nero al posto del blu e i soli al posto delle stelle. I brani sono lunghi e ipnotici, funk. Emergono gioielli pop come Family Affair.
Nomi come Miles Davis e Brian Eno lo citarono come ispirazione, sia da un punto di vista artistico che di tecnica di registrazione. Small Talk del 1974 è un buon lavoro, anche se è evidente che l’ispirazione incomincia a calare e che il livello compositivo sembra essersi adagiato su schemi prevedibili, come confermano High on You del 1975, Heard Ya Missed Me, Well I’m Back (1976), Back on the Right Track (1979). Ain’t but the One Way del 1982 è l’ultimo album di Sly Stone. Al suo fianco un gigante del funk come George Clinton dei Funkadelic.
Di Sly si perdono progressivamente le tracce, torna alle cronache quando viene arrestato per possesso di cocaina. Riemerge occasionalmente per sporadiche collaborazioni discografiche (con Funkadelic, Earth, Wind and Fire, Bobby Womack, Bar-Kays) che però non contribuiscono a distoglierlo dai suoi guai. Nel 1993 Sly and the Family Stone entrano nella Rock and Roll Hall of Fame. Introdotti nella cerimonia da George Clinton, improvvisano una spettacolare Thank You a cappella, in attesa che arrivi anche il loro leader, che si materializza per un solo minuto, in un completo azzurro elettrico, un taglio di capelli improbabile, condizioni fisiche precarie, parla per venti secondi e scompare di nuovo.
Tornerà nel 2007 con una serie di apparizioni con la Family Stone. Nel 2011 esce I’m Back! Family and Friends. La presenza di grandi della musica come Ray Manzarek, Jeff Beck, Johnny Winter, George Clinton, Ann Wilson non solleva il disco da una trascurabile mediocrità.
(billboard.it)
Il 20 aprile di 50 anni gli Sly & The Family Stone si affacciarono per la prima volta nell’hit parade statunitense raggiungendo l’ottavo posto grazie al 45 giri Dance to the Music. La settimana dopo uscì l’omonimo long playing, doppiato ad appena cinque mesi di distanza dall’interlocutorio Life. Everyday People, datato 1968, scalò la classifica dei singoli fino alla vetta e aprì la strada all’album Stand!, destinato a diventare assoluto best seller del gruppo. Già protagonista a luglio (insieme a Led Zeppelin, Miles Davis, Frank Zappa e Sun Ra) del Newport Jazz Festival, la band si esibì il 17 agosto a Woodstock, dopo Janis Joplin e prima degli Who. Impressionante il colpo d’occhio, immortalato nel documentario sul festival diretto da Michael Wadleigh: costumi da Era dell’Aquario, acconciature afro, vibrazione trance, coreografie stile Broadway. Quella degli Sly & The Family Stone era una rivoluzione artistica che incarnava lo Zeitgeist: l’utopia degli hippie a braccetto con il Black Power, comunione simboleggiata dall’assetto multirazziale dell’organico (sei neri e due bianchi), al quale corrispondeva una pluralità di genere (cinque uomini e tre donne). La musica: gospel e doo wop nell’intreccio delle voci, un impeto ritmico alla James Brown, melodie a presa rapida dal gusto Motown e arrangiamenti di scuola Stax, il basso distorto dal fuzz ammiccava al garage rock e il wah wah della chitarra sapeva di psichedelia.
Sly Stone divenne icona afroamericana nella stagione del Flower Power. L’influenza esercitata fu enorme: tanto fra i contemporanei (il suono della Motown cambiò per emulazione, così come il jazz attraverso Miles Davis) quanto in epoche successive (dal funk avveniristico di Prince all’hip hop caleidoscopico degli OutKast).

Nato a Denton, in Texas, il 15 marzo 1943, secondo di cinque figli in una famiglia devota alla Church of God in Christ, Sylvester Stewart era cresciuto in un sobborgo di San Francisco chiamato Vallejo. Da bambino suonava le tastiere e cantava gospel insieme al fratello Freddie e alle sorelle Rose e Vaetta negli Stewart Four, artefici di un 78 giri nel 1952, dopodiché iniziò ad armeggiare con chitarra, basso e batteria, oltre a fare doo wop nei Viscaynes e realizzare alcuni 45 giri da solista (Danny Stewart) o in gruppo (Stewart Brothers). Rese pubblico lo pseudonimo con cui diventò celebre nel 1962, facendo il DJ in radio su KSOL (a Frisco) e KDIA (a Oakland), dove alternava pezzi di rhythm’n’blues ad altri degli “invasori britannici” Beatles e Rolling Stones.
Fu reclutato poi dall’etichetta discografica Autumn, per conto della quale produsse dischi di Bobby Freeman, Mojo Men, Beau Brummels e Great Society (futuri Jefferson Airplane). Tra il 1964 e il 1966 radunò il nucleo di musicisti che lo avrebbe affiancato di lì in avanti: familiari (Freddie alla chitarra e Vaetta ai cori, raggiunti nel 1968 da Rose, voce e tastiere), partner (la trombettista Cynthia Robinson, cugina del bassista Larry Graham) e amici di pelle chiara (il sassofonista Jerry Martini e il batterista Greg Errico). Preceduto dal singolo Underdog, l’album d’esordio di Sly & The Family Stone uscì nell’ottobre 1967 annunciato da un titolo programmatico: A Whole New Thing.
Nel momento del trionfo, la storia degli Sly & the Family Stone prese una brutta piega: Sly era un ragazzo ingenuo e Bel Air gli fece esplodere il cervello. Divenne ostaggio di magnaccia, spacciatori di coca e trafficanti, gente che lo adulava. Gli effetti collaterali furono evidenti: forfait ai concerti e conflitti con il pubblico, avendo sempre intorno una corte dei miracoli degna di un romanzo di James Ellroy, tra guardie del corpo armate con cani al guinzaglio, pusher e malavitosi. Una vita sospesa fra paranoia e megalomania. L’album There’s a Riot Goin’ On, fu un’opera cupa, che fotografava lo stato delle cose: le Black Panthers in dissoluzione e l’utopia hippie in frantumi. In copertina: la bandiera americana con fiori al posto delle stelle.
Da lì in poi fu uno stillicidio: per primo se ne andò Errico, imitato ben presto da Graham, e la parabola imboccò la traiettoria discendente. Dopo il matrimonio con l’attrice Kathy Silva, celebrato sul palco del Madison Square Garden il 5 giugno 1974 di fronte a diecimila spettatori, seguito da un rapido divorzio, ad abbandonarlo furono i “familiari” Rose e Freddie. La bancarotta finanziaria era dietro l’angolo e i problemi con la legge dovuti al possesso di stupefacenti portarono a ripetuti arresti. Tra un’overdose in Florida e tentativi di disintossicazione, l’inizio degli anni Ottanta si tramutò in un calvario. Per un po’ sparì dalla circolazione, salvo riaffiorare in modo sporadico e spesso catastrofico durante i due decenni seguenti, tipo alla cerimonia dei Grammy Awards nel 2006 (moicano biondo, occhiali da sole scuri, cappotto argentato), a Montreux nel 2007 e al Coachella del 2010, a traino della Family. Per qualche tempo ha vissuto in un camper ricevendo sussidi sociali. Siccome era in vertenza con l’ex manager Jerry Goldstein, non percepiva alcun reddito dalle royalties. E nel 2011 ha pubblicato addirittura un disco, I’m Back! Family & Friends (tra gli ospiti: Jeff Beck e Ray Manzarek), facendo cover di sé stesso.